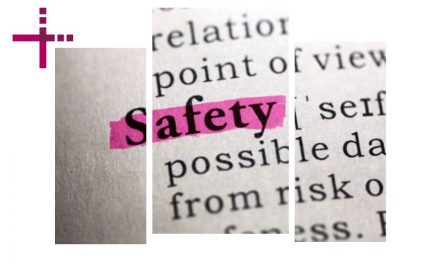LA PROGETTAZIONE DEGLI ALBERI DI TRASMISSIONE

Gli alberi di trasmissione rappresentano componenti critici in applicazioni che spaziano dall’industria automobilistica agli impianti industriali ad alta potenza; essi infatti trasferiscono potenza, mantengono il posizionamento relativo tra elementi collegati e influenzano direttamente affidabilità e prestazioni. L’obiettivo di questo articolo è fornirne un’idea generale utile alla progettazione.
Alberi o Assi?
Un albero è un organo rotante, solitamente a sezione circolare, utilizzato per trasmettere potenza o movimento. Esso fornisce l’asse di rotazione, o di oscillazione, di elementi come ingranaggi, pulegge, volani, manovelle, ruote dentate a catena e simili, e ne controlla la geometria del moto. Un asse è invece un elemento non rotante che non trasmette coppia e viene utilizzato per supportare ruote, pulegge e altri organi rotanti. L’assale automobilistico non è un vero asse; il termine deriva dall’epoca delle carrozze trainate da cavalli, quando le ruote ruotavano su elementi fissi.
Materiali per alberi
L’occorrere delle deformazione non dipende dalla resistenza, bensì dalla rigidezza, rappresentata dal modulo di elasticità E, che è sostanzialmente costante per tutti gli acciai. Per questo motivo, la rigidezza non può essere controllata tramite la scelta del materiale, ma solo attraverso le decisioni geometriche. In molti casi è sufficiente impiegare acciai a basso o medio tenore di carbonio, laminati a freddo o a caldo, che risultano economici e facili da lavorare. L’uso di acciai legati e trattamenti termici avanzati non sempre è giustificato: infatti, se è vero che un incremento della resistenza può migliorare il comportamento a fatica, tale beneficio si arresta oltre una certa soglia, a causa dell’aumento della sensibilità agli intagli e della riduzione del limite di resistenza.
Il criterio progettuale generalmente seguito prevede di partire con un materiale semplice ed economico. Se in fase di calcolo emergesse che le sollecitazioni prevalgono sul problema delle deformazioni, è possibile ricorrere a un acciaio più resistente, riducendo così i diametri dell’albero fino a quando non si manifestano eccessive flessioni o torsioni. In ogni caso, la scelta finale deve considerare anche il rapporto costi/benefici legato al materiale e ai trattamenti.
Gli alberi non necessitano quasi mai di indurimenti superficiali, tranne quando devono funzionare direttamente come sedi di cuscinetti; in questi casi si applicano trattamenti di carbocementazione. L’acciaio laminato a freddo viene usato soprattutto per diametri contenuti, mentre per alberi di grandi dimensioni si preferisce quello laminato a caldo, il quale richiede però lavorazioni più estese e può presentare problemi di tensioni residue.
Un ulteriore criterio di scelta è legato ai volumi produttivi. Nelle piccole serie la tornitura è la soluzione più economica, mentre per produzioni elevate risulta più conveniente impiegare processi di formatura a caldo o a freddo, o la fusione, con l’obiettivo di ridurre il materiale utilizzato. In particolare, la ghisa può essere vantaggiosa quando si producono alberi con ingranaggi integrati.
Collegare gli elementi per trasmettere la coppia
La funzione principale degli alberi consiste nella trasmissione della coppia da un organo di ingresso, quale un ingranaggio o una puleggia, a un organo di uscita analogo, mediante l’albero stesso. Di conseguenza, quest’ultimo deve essere opportunamente dimensionato per resistere alle sollecitazioni torsionali e alle deformazioni angolari che ne derivano. Inoltre, è necessario prevedere un adeguato sistema di collegamento che consenta il trasferimento della coppia tra l’albero e i componenti calettati.
Tra i dispositivi comunemente utilizzati a tale scopo si annoverano linguette, scanalature longitudinali, grani, perni, accoppiamenti a pressione o per interferenza e accoppiamenti conici. Molti di questi elementi sono concepiti in modo da cedere qualora il valore della coppia superi i limiti di esercizio ammissibili, così da proteggere i componenti di maggior costo.
Uno dei metodi più diffusi ed economicamente vantaggiosi per trasmettere coppie medio-alte consiste nell’impiego di una linguetta inserita in una cava ricavata sull’albero e sul mozzo del componente. Tale soluzione prevede un accoppiamento di scorrimento, che agevola le operazioni di montaggio e smontaggio, e garantisce al contempo un vincolo angolare positivo, particolarmente utile nei casi in cui la fasatura angolare riveste importanza.
Le scanalature longitudinali rappresentano un’alternativa tecnica, costituita da denti corti ricavati sulla superficie dell’albero e corrispondenti gole interne nel mozzo. Sebbene più onerose in termini produttivi rispetto alle linguette e non sempre necessarie in applicazioni ordinarie, esse trovano impiego per la trasmissione di coppie elevate. Un ulteriore vantaggio delle scanalature risiede nella possibilità di adottare accoppiamenti con gioco, che consentono significativi spostamenti assiali tra albero e componente pur mantenendo la trasmissione della coppia. Questa caratteristica risulta utile in applicazioni quali i collegamenti di alberi per la presa di forza dei trattori. Le norme di riferimento sono fornite da SAE e ANSI.
Per applicazioni caratterizzate da bassi valori di coppia sono disponibili ulteriori sistemi, quali perni, grani su mozzi, accoppiamenti conici o per interferenza. Gli accoppiamenti a pressione e per interferenza sono ampiamente utilizzati sia per la trasmissione della coppia sia per assicurare il corretto posizionamento assiale del componente. Essi determinano fattori di concentrazione degli sforzi generalmente contenuti.
Gli accoppiamenti conici tra albero e organo calettato, come ad esempio le ruote, sono spesso impiegati alle estremità libere dell’albero. In tali configurazioni, una filettatura terminale consente l’uso di un dado di bloccaggio per fissare l’organo con elevata forza di serraggio. Questa soluzione presenta il vantaggio di un facile smontaggio, ma non assicura un vincolo assiale preciso del componente.
In fase preliminare di progettazione dell’albero è fondamentale selezionare il metodo di trasmissione della coppia più idoneo e valutarne le conseguenze sulla configurazione complessiva. È infatti necessario definire con precisione la posizione delle discontinuità geometriche, quali cave, fori o scanalature, al fine di individuare le sezioni critiche da sottoporre a verifica strutturale.

Calcolo delle sollecitazioni e delle deformazioni
Diversamente, le analisi relative alle deformazioni e alle inclinazioni non possono essere effettuate senza una conoscenza completa della geometria dell’albero, in quanto tali grandezze dipendono dal comportamento globale della struttura. La sollecitazione in una sezione, infatti, è funzione della geometria locale, mentre la deformazione è funzione della geometria complessiva. Per questa ragione, l’approccio metodologico alla progettazione degli alberi prevede di eseguire prioritariamente l’analisi delle sollecitazioni. Solo in un secondo momento, una volta stabilite le dimensioni preliminari dell’albero, è possibile condurre le verifiche di deformazione e di inclinazione, così da garantire adeguata rigidezza e funzionalità del sistema.
La flessione dell’albero è invece analizzabile attraverso i diagrammi del taglio e del momento flettente. Poiché ingranaggi e pulegge applicano forze in direzioni diverse, è spesso necessario costruire i diagrammi in due piani ortogonali e sommare i momenti risultanti come grandezze vettoriali. L’angolo di fase non ha rilevanza, poiché l’albero è in rotazione continua: ciò comporta che un momento flettente costante generi una sollecitazione alternata, con cicli di compressione e trazione che si ripetono a ogni giro. Anche in questo caso, le tensioni più elevate si concentrano sulla superficie esterna. Viceversa, in corrispondenza delle estremità dell’albero, dove sono collocati i cuscinetti di supporto, i momenti flettenti si riducono e le sollecitazioni diventano generalmente trascurabili.
Per quanto riguarda le forze assiali, esse possono originare da componenti come ingranaggi elicoidali o cuscinetti a rulli conici, ma la loro entità è di norma molto più bassa rispetto a quella dovuta ai momenti flettenti. Inoltre, trattandosi spesso di carichi costanti, il loro contributo alla fatica è marginale. Pertanto, è usuale considerarle irrilevanti nei calcoli, a meno che non vengano applicati carichi assiali significativi di altra natura. In tali casi, una valutazione specifica diventa indispensabile per evitare errori di sottostima.
Calcolo delle sollecitazioni e delle deformazioni
Diversamente, le analisi relative alle deformazioni e alle inclinazioni non possono essere effettuate senza una conoscenza completa della geometria dell’albero, in quanto tali grandezze dipendono dal comportamento globale della struttura. La sollecitazione in una sezione, infatti, è funzione della geometria locale, mentre la deformazione è funzione della geometria complessiva. Per questa ragione, l’approccio metodologico alla progettazione degli alberi prevede di eseguire prioritariamente l’analisi delle sollecitazioni. Solo in un secondo momento, una volta stabilite le dimensioni preliminari dell’albero, è possibile condurre le verifiche di deformazione e di inclinazione, così da garantire adeguata rigidezza e funzionalità del sistema.
La flessione dell’albero è invece analizzabile attraverso i diagrammi del taglio e del momento flettente. Poiché ingranaggi e pulegge applicano forze in direzioni diverse, è spesso necessario costruire i diagrammi in due piani ortogonali e sommare i momenti risultanti come grandezze vettoriali. L’angolo di fase non ha rilevanza, poiché l’albero è in rotazione continua: ciò comporta che un momento flettente costante generi una sollecitazione alternata, con cicli di compressione e trazione che si ripetono a ogni giro. Anche in questo caso, le tensioni più elevate si concentrano sulla superficie esterna. Viceversa, in corrispondenza delle estremità dell’albero, dove sono collocati i cuscinetti di supporto, i momenti flettenti si riducono e le sollecitazioni diventano generalmente trascurabili.
Per quanto riguarda le forze assiali, esse possono originare da componenti come ingranaggi elicoidali o cuscinetti a rulli conici, ma la loro entità è di norma molto più bassa rispetto a quella dovuta ai momenti flettenti. Inoltre, trattandosi spesso di carichi costanti, il loro contributo alla fatica è marginale. Pertanto, è usuale considerarle irrilevanti nei calcoli, a meno che non vengano applicati carichi assiali significativi di altra natura. In tali casi, una valutazione specifica diventa indispensabile per evitare errori di sottostima.
Oscillazioni torsionali degli alberi
Nella maggior parte dei casi, il momento torcente applicato agli alberi non è costante, ma presenta una variabilità periodica. Tale momento può essere pertanto rappresentato mediante una scomposizione in serie di Fourier, definita sull’intervallo pari al periodo del moto. In altre parole, esso può essere considerato come la somma di momenti parziali, o armoniche del momento motore, che variano secondo leggi sinusoidali, con frequenze crescenti proporzionalmente ai numeri interi successivi.
L’albero, unitamente alle masse ad esso applicate, direttamente o indirettamente – quali giunti, pulegge, volani o organi di imbiellaggio – costituisce un sistema dinamico in grado di vibrare torsionalmente con specifiche frequenze proprie in funzione della velocità.
Ne consegue il rischio che una di tali frequenze naturali coincida o risulti prossima a quella di una delle armoniche del momento torcente. In tali condizioni può manifestarsi il fenomeno di risonanza tra l’armonica considerata e la frequenza propria del sistema, con conseguente incremento dell’ampiezza delle oscillazioni. È tuttavia opportuno sottolineare che la risonanza non implica necessariamente ampiezze illimitate o rottura del componente, in quanto le forze dissipative, interne o esterne, possono mantenere l’ampiezza entro limiti finiti.
Poiché l’ampiezza delle armoniche decresce generalmente con l’aumentare della frequenza, e quindi della velocità di rotazione, il pericolo di oscillazioni eccessive risulta più significativo quando l’armonica in risonanza è tra le prime, ovvero quelle a frequenza più bassa.
Lo studio delle oscillazioni torsionali si articola pertanto in tre aspetti fondamentali:
- la determinazione delle frequenze proprie del sistema albero-volani (dove si intende con il termine “volani” tutte le masse applicate, direttamente o indirettamente, all’albero, le quali contribuiscono a ridurne la frequenza naturale);
- l’analisi armonica del momento torcente, includendo l’effetto dell’inerzia degli organi di imbiellaggio nei motori a combustione interna;
- la valutazione delle condizioni di risonanza e delle ampiezze delle oscillazioni associate, considerando gli smorzamenti presenti, con l’obiettivo di stimare l’incremento della sollecitazione unitaria nelle condizioni di massimo rischio.
Tali analisi risultano intrinsecamente complesse e richiedono l’utilizzo di software di simulazione che utilizzano numerose ipotesi semplificative e dati sperimentali che non sempre risultano perfettamente coerenti. Tuttavia, se i dati sperimentali e la quantificazione degli effetti smorzanti vengono selezionati e utilizzati con criterio, le simulazioni forniscono generalmente previsioni in buon accordo con l’esperienza pratica.
Il ruolo del fornitore di componenti
La progettazione di soluzioni per la trasmissione del moto può trovare un valido supporto nei fornitori di componenti.
È il caso di R+W, azienda leader nella produzione di giunti e alberi di trasmissione, in grado di mettere la sua esperienza a disposizione del progettista. R+W fornisce soluzioni specifiche per le esigenze di trasmissione e controllo della coppia. In questi campi i giunti più utilizzati sono i giunti a elastomero EK.
La calibrazione dell’inserto in elastomero garantisce una trasmissione senza gioco e la perfetta adesione alle sedi dell’elastomero ricavate nei mozzi, garantendo un’elevata concentricità per un funzionamento preciso.
La capacità di smorzamento dei giunti in elastomero può avere un effetto particolarmente positivo sulla durata delle apparecchiature adiacenti, soprattutto in caso di vibrazioni, carico d’urto e movimenti dinamici.